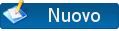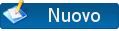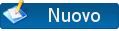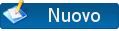|
RE: [OT] Discussione in libertà (Piazzetta)
http://www.loccidentale.it/node/112437
Paradosso persiano/ 1
La rivoluzione khomeinista ha avuto un solo effetto: isolare l'Iran
di Andrea Milluzzi e Linda Dorigo 3 Gennaio 2012
Teheran - Come il 1979? L'assalto degli "studenti" iraniani all'ambasciata inglese di Teheran del 29 novembre scorso ha riportato subito alla mente quanto successo all'indomani della rivoluzione khomeinista, quando centinaia di giovani rivoluzionari fecero irruzione nell'ambasciata americana e tennero 63 persone in ostaggio per 444 giorni.
E' facile azzardare un paragone fra oggi e allora, ma le immagini dalla capitale iraniana con decine di uomini intenti a bruciare l'Union Jack sopra il cancello della sede diplomatica britannica non bastano a giustificarlo.
L'Iran prima della rivoluzione islamista era un Paese centrale nello scacchiere geopolitico mondiale, lo Shah Reza Pahlavi vantava rapporti economici e personali con le maggiori potenze occidentali e la società iraniana era aperta all'esterno, grazie al turismo, ai mezzi di comunicazione e ad un passaporto che quasi ovunque non subiva restrizioni.
Adesso la Repubblica Islamica è alle prese con un isolamento internazionale senza precedenti: inserita dal 2008 nella lista degli “Stati canaglia” stilata dall'amministrazione Usa di George W. Bush, sottoposta ad un embargo internazionale per il suo programma di sviluppo nucleare che rende difficilissimo il commercio e le transazioni bancarie e finanziarie, condannata da ogni dove per le posizioni antisemite e negazioniste nei confronti di Israele.
Oggi come allora a pagare il prezzo più alto per la politica del suo Governo e le decisioni internazionali è sempre la popolazione iraniana. Il benessere e lo sviluppo propiziati dallo Shah erano privilegi per una minoranza degli iraniani, soprattutto per la classe medio-alta delle città, mentre nelle campagne permaneva l'analfabetismo e la mancanza di infrastrutture. Il laicismo imposto dalla dinastia Pahlavi, oltre alla corruzione e agli sfarzi di corte, continuamente ostentati in pubblico per accrescere il lustro della "grande Persia", non faceva altro che alimentare l'astio di una società gelosa delle sue radici e distante da un modello di vita troppo occidentale. Indossare il hijab era proibito, ma per molte donne avere la testa coperta da un velo era un segno di appartenenza e di rispetto di antiche tradizioni.
Specialmente negli ultimi anni del suo regno Reza Pahlavi si lanciò in spese folli e populiste (beni di consumo, armamenti militari) che stridevano clamorosamente con una rete di servizi e di infrastrutture assai carente e con una disoccupazione e un'inflazione giunte a livelli non più controllabili.
La paura di perdere il potere aveva indotto lo Shah a rafforzare la polizia segreta, la Savak, che pattugliava giorno e notte le vie delle città con orecchie tese ad ascoltare qualsiasi critica, diretta o meno, al sovrano e ai suoi fedeli. Sempre attraverso la Savak e l'esercito, il regime si premurava di sedare qualsiasi tentativo di ribellione e di perseguitare ed arrestare gli avversari politici, dai sindacati agli intellettuali, dal partito comunista Tudeh agli ulema seguaci dell'ayatollah Khomeini, già costretto in esilio a Najaf, in Iraq prima e a Parigi poi.
La rivoluzione che ne seguì aveva quindi un terreno fertile per coinvolgere attori diversi fra loro, tanto che molti degli osservatori internazionali che avevano salutato con entusiasmo il cambiamento iraniano, all'insegna di una maggiore libertà, non furono capaci di prevedere quello che sarebbe successo subito dopo.
La debolezza e le divisioni di molte componenti della rivoluzione, dai comunisti ai sindacati passando per gli intellettuali e l'esercito, favorirono la presa egemone del potere da parte del clero religioso che in breve tempo riuscì ad organizzare un referendum per il passaggio dalla monarchia alla repubblica islamica, che venne stravinto con il 98% dei voti. Alla trasformazione dell'Iran in un Paese guidato dai dettami dell'Islam si accompagnò l'epurazione dei nemici interni, marchiando con l'epiteto di "infedele" chiunque si opponesse al regime o tradisse, seconda la visione dei mullah e ulema, gli ideali della rivoluzione.
Cancellati i sindacati, i comunisti e buona parte dell'esercito e ridotto al silenzio il mondo intellettuale, il consiglio supremo della rivoluzione, maggior organo costituzionale guidato da Khomeini fino alla sua morte, rimase il padre-padrone dell'Iran.
Credendo che le divisioni interne avessero indebolito l'esercito e il dinamismo politico dell'antico nemico confinate, il raìs iracheno Saddam Hussein attaccò l'Iran il 22 settembre 1980, con la benedizione dell'amministrazione statunitense di Ronald Reagan.
I successivi otto anni di guerra fra i due confinanti non produssero un chiaro vincitore, ma ebbero come sole conseguenze un milione di iraniani morti e circa 700 miliardi di dollari di costi. Sul piano politico il patriottismo diffuso a profusione dal regime consolidò la rivoluzione khomeinista e mise a tacere ogni speranza di cambiamento, gettando gli iraniani da un regime all'altro.
Durante i trenta e più anni che sono intercorsi dalla cacciata dello Shah ad oggi, il regime iraniano ha prima cercato di esportare la rivoluzione sciita nei Paesi confinanti, poi si è ritrovato chiuso nei confini territoriali, osteggiato sia dai potenti vicini dell'Arabia Saudita sia da potenze occidentali quali Usa, Inghilterra e da Israele. Un isolamento accentuato dall'ascesa al Governo dell'attuale presidente Mahmud Ahmadinejad che, con le provocazioni contro Israele e l’ambiguità sulla corsa al nucleare, ha provocato le reazioni dell'Occidente, sempre sfociate in sanzioni economiche e finanziarie.
In realtà il progetto nucleare è una costante della storia dell'Iran, da sempre alla ricerca di un approvvigionamento energetico diverso da petrolio e gas, di cui è rispettivamente terzo e secondo produttore al mondo e la cui esportazione è la principale, se non unica, fonte di ricchezza nazionale. Ma l'Iran è un Paese di 70 milioni di abitanti che quotidianamente fanno uso di vecchie auto e camion che hanno bisogno di benzina. Così, dei 4.031 milioni di barili di petrolio estratti ogni giorno, solo 2.476 finiscono sul mercato, mentre gli altri sono destinati al consumo interno. Togliere questa merce dalle forniture all'estero significa però guadagnare meno, senza considerare che la fornitura di benzina in Iran è razionata.
I governi iraniani che si sono succeduti hanno quindi cercato da sempre una via alternativa per l'approvvigionamento energetico, puntando sul nucleare. Lo Shah firmò con Washington un trattato di cooperazione nucleare al servizio della pace nel 1957 e nel 1970 l'Iran fu tra i firmatari del trattato di non proliferazione nucleare. Lo stesso Shah si rese conto in seguito della necessità di diversificare e arricchire le fonti di approvvigionamento energetico e dal 1974 al 1978 spese 8 miliardi di dollari per la progettazione di una ventina di centrali nucleari che avrebbero dovuto fornire all'Iran un quarto dell'elettricità necessaria nell'arco di 20 anni. Subito dopo la rivoluzione del 1979 il progetto nucleare venne sospeso, ma la sete di energia riprese ben presto.
Gli Ayatollah cercarono partner stranieri per la costruzione delle centrali e consulenze sul caso ma nessuno, tranne Mosca, accolse la richiesta iraniana. La tecnologia russa era però diversa da quelle tedesche e francesi con cui lo Shah aveva iniziato a lavorare. Fu così necessario convertire l'impianto di Busher, la prima delle centrali nucleari costruite sul territorio, tanto che il progetto nucleare si arenò per qualche anno. Fu con la presidenza Khatami prima e, soprattutto con il Governo Ahmadinejad poi, che il nucleare iraniano tornò prepotentemente alla ribalta della cronaca.
Oltre al mero calcolo energetico, l'Iran è interessato a diventare una potenza nucleare anche per ragioni di principio: due ex colonie dell'area, Pakistan ed India, hanno la bomba atomica, così come ce l'ha Israele, nemico giurato.
Per scoraggiare qualsiasi intenzione bellica dei confinanti, o viceversa per incutere loro timore, l'arricchimento del nucleare è un'arma preziosa. Infine gli Ayatollah, come i due Shah prima di loro, non hanno mai abbandonato il sogno di fare dell'odierno Iran un impero regionale che possa ricalcare i fasti dell'antica Persia e spaventare il mondo con la minaccia nucleare fa parte di questo progetto.La condanna della comunità internazionale sul nucleare iraniano riguarda l'atteggiamento circospetto che i governi hanno tenuto sulla vicenda.
Alle richieste di aprire le porte delle centrali e di inviare documentazione all'Aiea (Agenzia internazionale per l'energia atomica) sono giunte da Tehran risposte contraddittorie e a volte addirittura dinieghi. La costruzione di Busher fu tenuta nascosta all'Aiea che, nel 2005, riscontrò violazioni al protocollo internazionale nella centrale di Isfhan e mise i sigilli al sito di Natanz (sigilli poi tolti dai funzionari iraniani, mossa che acuì la paura dell'Occidente).
Nel 2007 Ahmadinejad annunciò che l'Iran sarebbe stato in grado di produrre 1300 centrifughe e l'anno successivo l'esercito iraniano testò un missile a media gittata in grado di raggiungere anche Israele. L'ultimo allarme Aiea viene lanciato l'8 novembre scorso con un rapporto basato su informazioni avute da personaggi chiave del programma nucleare iraniano (probabilmente un tecnico russo incaricato del programma stesso):
"L’Iran si trova in uno stadio avanzato nella costruzione della bomba atomica, smentendo gli scopi esclusivamente civili dell’arricchimento di uranio sostenuti dal regime di Teheran, ed è già in possesso di missili come gli Shahab-3, sui quali può essere montata una testata nucleare, che, con una gittata di 2.000 chilometri, è in grado di colpire Israele.
Il Paese sta inoltre lavorando allo sviluppo delle versioni successive (Shahab 4 e 5), che sarebbero in grado di raggiungere l’Europa”.
In seguito a questo rapporto, Israele ha minacciato di attaccare l'Iran prima che sia troppo tardi, mentre la comunità internazionale ha varato nuove pesanti sanzioni contro esponenti del regime e l'economa iraniana, banche in primis.
Da oltre 30 anni l'Iran è sottoposto a sanzioni e restrizioni da parte della comunità internazionale (quasi sempre approvate con la contrarietà di Russia e Cina, importanti partner commerciali della Repubblica islamica). Però queste limitazioni all'economia e al commercio, unite alla dilagante corruzione del Governo e ad un meccanismo produttivo autoreferenziale, visto che lo Stato deve essere presente almeno al 60% in ogni attività industriale intrapresa, hanno avuto come risultato più immediato di peggiorare nettamente il tenore di vita della popolazione iraniana.
Prima dell'ultima tornata di sanzioni la situazione delle famiglie iraniane era già al limite: nell'estate 2011 il Governo di Ahmadinejad ha portato a 400.000 ryal (poco più di 27 euro) il sussidio statale mensile alle famiglie. Parallelamente però l'inflazione è schizzata a volte del 700%: un chilo di pane, che costava 5000 Ryal, ad agosto era salito a 2.300 (poco più di un euro e mezzo), un litro di latte da 1.000 ryal a 7.000, il biglietto del bus da 100 a 300, per un litro di benzina si spendevano 4.000 ryal.
Anche gli affitti di case e appartamenti sono paragonabili ad una media capitale europea e la sanità è un lusso che si può permettere solo chi ha i soldi necessari a pagarsi un'assicurazione privata. ( continua)
Una fredda nebbia illividisce il cielo,
le notti incominciano prima.
Tutti conoscono il declino,
ma pochi ne discernono la linea di confine.
Cher03@hotmail.it
|