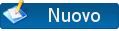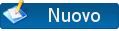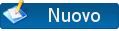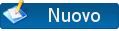|
RE: Vita, morte e miracoli dell'Energia Nucleare
1. – Il “Puzzle” dell’uranio e la scoperta della “fissione”
Nei giorni immediatamente precedenti il Natale 1938, due chimici tedeschi Hahn e
Strassmann, dell’Istituto di Chimica della Kaiser Wilhelm Gesellschaft (nel seguito KWI)
di Berlino-Dalhem scoprono, con immenso stupore ma senza ombra di dubbio, che l’uranio
(numero atomico Z = 92) colpito da neutroni termici di una sorgente radio-berillio
d`a luogo alla produzione di atomi di bario (Z = 56). Fenomeno per loro inspiegabile dato
che nelle precedenti quasi decennali ricerche di irrraggiamento con neutroni le reazioni
(n, γ , e conseguente successiva emissione β, davano luogo ad elementi contigui con numero , e conseguente successiva emissione β, davano luogo ad elementi contigui con numero
atomico Z + 1, ma mai con numeri atomici cos`ı lontani, nella scala di Mendelejev,
come Ba e U con Z distanti di ben 36 posti.
I risultati ottenuti dai due chimici tedeschi con raffinate tecniche di precipitazione e
cristallizzazione frazionate erano tuttavia incontrovertibili: un ulteriore controllo prov`o
che nella stessa soluzione di sali di U erano presenti anche atomi di lantanio (Z = 57)
prodotti dal decadimento β del Ba.
La scoperta di Hahn e Strassmann apriva un nuovo capitolo della straordinaria vicenda
scientifica dell’irraggiamento dell’U iniziata con la pubblicazione su “Nature” del
giugno 1934 del famoso articolo di Fermi e del suo gruppo romano “Possible Production
of Elements of Atomic Number Higher than 92” (1) nel quale, sia pure con molte cautele,si suggeriva l’ipotesi della creazione di elementi transuranici: vero e proprio puzzle scientifico
nel quale si erano cimentati per quasi cinque anni i maggiori fisici e radiochimici
europei (2).
Otto Hahn (futuro Premio Nobel proprio per questa scoperta) non poteva purtroppo
pi`u contare in quei giorni sul consiglio della sua stretta collaboratrice ed amica Lise
Meitner, una fisica austriaca che lavorava con lui fin dal 1935, ma che essendo ebrea
aveva dovuto lasciare il KWI sin dal luglio 1938, rifugiandosi a Stoccolma dove aveva
ripreso la sua attivit`a di ricerca.
Hahn, che non voleva rinunciare al suo giudizio, decise di scriverle una lettera chiedendone
i lumi (“Forse tu puoi suggerire qualche fantastica spiegazione”) e inviandole successivamente
la copia carbone del dattiloscritto dell’articolo da lui inviato il 22 dicembre alla
rivista tedesca “Naturwissenschaften” e che comparir`a nel fascicolo del 6 gennaio 1939.
L’attesa risposta sarebbe arrivata con qualche giorno di ritardo dovuto al fatto che
proprio in quei giorni la Meitner si trovava in vacanza in una stazione sciistica della
Svezia Meridionale in compagnia del nipote Otto Frisch, fisico anch’egli, esule da Vienna
nell’Istituto di Niels Bohr a Copenhagen.
La vacanza di sci doveva rivelarsi poi oltremodo fortunata e fruttuosa. Zia e nipote
colpiti dalla stranezza dei risultati berlinesi si misero immediatamente e animatamente a
discutere giungendo alla conclusione che si trattava della scissione del nucleo di U in due
frammenti di massa intermedia, uno dei quali era il bario. Il fenomeno secondo loro era del
tutto compatibile con il modello a goccia di Bohr del nucleo atomico. L’energia di legame
del neutrone catturato avrebbe fornito al nucleo composto U + n l’energia necessaria
per innescare una serie di oscillazioni tanto violente da produrre un allungamento della
“goccia” tale da farle assumere un configurazione instabile a forma di “manubrio” da
ginnastica (fig. 1): le due quasi sfere alle estremit`a si sarebbero allontanate per repulsione
elettrostatica sotto forma di frammenti con la conseguente liberazione di una notevole
quantit`a di energia. Questa sarebbe stata fornita a spese della differenza di masse ΔM
fra il nucleo di U e la somma delle masse dei due frammenti: in base al diagramma
di Aston, ΔM doveva essere positivo. Con il semplice uso della famosa equazione di
Einstein E = ΔM · c2. Zia e nipote stimarono che l’energia liberata dalla scissione dell’U
sarebbe stata dell’ordine di circa 200 MeV valore molto elevato dato che il difetto di
massa ΔM era pari a circa 1/5 della massa di un nucleone. Frisch e Meitner potevano
cos`ı spiegare i risultati dei chimici del KWI di Berlino, anticipando in tal modo i risultati
a cui sarebbero giunti molti mesi pi`u tardi, con metodi teorici molto pi`u raffinati, Bohr
e Wheeler in un famoso articolo pubblicato su “Physical Review” l’1 settembre 1939 (3).
"Io non ho paura del nucleare ma dell'uomo !" giampiero giulianelli
|