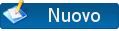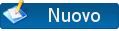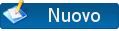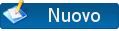|
RE: Società Italiana per il Progresso delle Scienze
http://www.sipsinfo.it/SeT%20gen-feb%202010.pdf
LA NATURA*
* (Seconda parte dello scritto di Edoardo Boncinelli apparso in “Idea di natura - 13 scienziati a confronto”, curato da Elio Cadelo
con la prefazione dì Corrado Clini.)
LA COMPRENSIONE DELLE LEGGI DELLA NATURA
La nostra comprensione della natura, e più precisamente della natura, è enormemente avanzata negli ultimi tempi, senza che si possa dire per questo che abbiamo compreso tutto.
Si è partiti originariamente dalla descrizione
e, poi, dalla comprensione dei fenomeni che riguardano le cose del nostro mondo quotidiano, quelle che siamo naturalmente attrezzati a osservare
e comparare. Si tratta di oggetti che hanno una dimensione fisica che va dai millimetri alle decine di chilometri e di eventi che si estendono
per un tempo che va dai secondi alle decine di anni. Tali entità costituiscono il nostro mondo, quello nel quale ci siamo evoluti e sviluppati.
Il culmine di questo processo si è avuto tra la
fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, quando sembrava che si fosse scoperto tutto e che almeno la fisica e la chimica non avessero più
alcun segreto. Nel primo quarto del Novecento ci siamo però trovati a dover ammettere che ci eravamo persi una grossissima fetta della realtà: il mondo dell’infinitamente piccolo e quello dell’infinitamente grande.
Due mondi che seguono principi assai diversi da quelli degli oggetti del nostro mondo quotidiano. Sono, infatti, dominati dalle leggi che appartengono a due grandi, bizzarre teorie fisiche comparse appunto in quel tempo: la fisica quantistica domina nel micromondo e la teoria della relatività generale nel gigamondo.
L’infinitamente piccolo mostra proprietà tutte sue, che lo distinguono da tutto ciò che ci è familiare. Le particelle elementari di cui è costituita
tutta la materia mostrano molte caratteristiche inconsuete, tra le quali la mancanza di un’individualità.
Tutti gli elettroni sono identici fra di loro, così come tutti i protoni o tutti i neutroni. Non è possibile, neppure in linea di principio, distinguere
un elettrone da un altro, in qualsiasi parte dell’universo questo si trovi. E non invecchiano.
Tali caratteristiche sono essenziali per la stabilità della materia, come è essenziale il fatto che anche l’energia, come la materia, abbia una
natura granulare o corpuscolare. Si è scoperto infatti, allora, che l’energia non può essere emessa o assorbita in quantità qualsiasi, ma che queste devono equivalere a multipli interi di un’unità fondamentale detta quanto d’energia. Si può trattare di 1 quanto, di 1000 quanti o di miliardi di miliardi di quanti, ma non di tre quanti e mezzo o di 16,28 quanti. Quando l’energia in gioco è molto grande, come succede nella maggior parte dei fenomeni quotidiani, è praticamente impossibile accorgersi del fatto che questa consiste di un numero intero di granuli, i quanti,appunto, dai quali la teoria prende il nome, e ciò spiega come
mai il fenomeno non era stato mai notato prima del XX secolo.
Se, però, si osservano processi che implicano una quantità di energia molto piccola, la sua natura quantistica si manifesta in tutta la sua evidenza.
Anche la luce ha una struttura granulare e consiste di un numero definito di quanti di luce, chiamati generalmente fotoni. Il punto fondamentale è che se la materia e l’energia non avessero una natura corpuscolare, il mondo stesso non esisterebbe.
Delle particelle che costituiscono la materia non è possibile, inoltre, conoscere troppe cose contemporaneamente. Di una particella posso
conoscere per esempio la posizione o la velocità, ma non tutte e due le cose contemporaneamente con precisione. Se ne conosco bene la posizione, avrò inevitabilmente una grande incertezza sulla sua velocità. Se al contrario conosco molto bene la sua velocità, dovrò accontentarmi di conoscerne solo approssimativamente la posizione. Qual è il motivo di una tale conoscenza parziale? Per misurare una grandezza è necessario uno strumento di misura, per quanto elementare. Per vedere con precisione dov’è un elettrone occorre almeno colpirlo con un raggio di luce elementare, cioè con un fotone. Questo impartisce inevitabilmente
all’elettrone una «spintina», così che non potrò mai sapere con precisione che velocità aveva prima che facessi la misura.
Semplicissimo ma profondamente inquietante.
Tra l’altro, si capisce perché questo non abbia importanza per esempio per una gomma da cancellare: se questa viene colpita da qualche fotone non ne riceve alcuna spinta e non ci sarà di conseguenza alcun incremento di velocità, se non infinitamente piccolo.
Un’analoga esclusione reciproca si osserva per l’energia e il tempo: non
è dato sapere qual è in questo preciso istante l’energia esatta posseduta da una particella.
Posso conoscerne esattamente l’energia solo se mi riferisco
a un intervallo di tempo piuttosto lungo,mentre se considero un intervallo molto breve devo rinunciare a conoscere con esattezza l’energia
posseduta.
Ma la cosa probabilmente più ardua da accettare è che una particella possa stare in più stati contemporaneamente, cioè in una mescolanza di
stati diversi. Non possiamo sapere per esempio che traiettoria ha percorso un elettrone di cui sappiamo che è andato da un punto A ad un punto B.
Si comporta, infatti, come se avesse percorso una combinazione di traiettorie diverse. Analogamente un elettrone che si trova all’interno di un atomo può trovarsi in molte posizioni diverse con livelli energetici diversi. È difficile comprendere perché sia così, affidandoci alla nostra mente abituata a corpi estesi e tempi relativamente lunghi, ma è
così. Pensandoci bene, però, come poteva essere altrimenti? Come poteva essere che questo tavolo avesse al suo interno dei pezzettini di legno e che dentro questi pezzettini di legno ci fossero altri pezzettini più piccoli e via discorrendo e che godessero tutti delle stesse proprietà?
Mentre per entità materiali molto piccole non si può fare a meno di mettere in campo l’apparato della meccanica quantistica, per oggetti più grandi come per i tavolini e per le sedie, come pure per gli esseri umani, invece, le vecchie formule vanno benissimo. Esiste a questo proposito un
principio che impone che ogni descrizione in termini quantistici debba trasformarsi progressivamente nella corrispondente descrizione classica
quando si passa dallo studio del mondo submicroscopico a quello dei corpi estesi e quindi dotati di una certa massa.
In questa luce, un elettrone lanciato contro una parete teoricamente insormontabile ha una certa probabilità di trovarsi, magicamente, dall’altra
parte. Questo fenomeno, chiamato effetto tunnel, ha luogo quotidianamente nel mondo delle particelle e l’uomo lo ha sfruttato per
costruire molti congegni elettronici. L’effetto tunnel vale ovviamente anche per le lepri e per gli esseri umani, ma perde progressivamente di
importanza fino a divenire irrilevante. Non è stato mai osservato un essere umano che lanciatosi contro una parete si sia trovato dall’altra parte, ovviamente senza romperla, anche se questo non
è teoricamente impossibile. Se si calcola infatti la probabilità che ciò accada, si vede che non è zero, ma è incredibilmente bassa.
Passare dalle particelle agli oggetti estesi ha anche questa conseguenza, come quella per cui noi viviamo in un mondo discretamente deterministico, mentre il micromondo segue principi probabilistici
o statistici. Nel nostro mondo, date certe condizioni di partenza, ne deve per forza seguire un certo corso degli eventi, in maniera determinata e prevedibile, almeno in linea di massima. Nel mondo delle particelle subatomiche,invece, le cose non stanno così.
Il comportamento della singola particella non è prevedibile nel suo dettaglio, nemmeno in linea di principio. Quello che è prevedibile è solo il comportamento di un gran numero di particelle messe nelle stesse
condizioni.
Il micromondo è quindi popolato di entità sfuggenti e misteriose che obbediscono a leggi ferree ma incomprensibili. Che dire, sull’altro versante, del gigamondo, quello che ospita entità enormi come pianeti, stelle, galassie e ammassi di galassie e dell’universo stesso? All’interno degli astri ci sono le particelle e talvolta gli atomi.
Questi e quelle seguono le leggi della fisica quantistica e la luce che molti corpi celesti emettono è una conseguenza dell’azione di queste strane
leggi. Al di fuori dei corpi celesti esiste lo spazio interstellare, anzi lo spazio-tempo interstellare con le sue proprietà.
Nel secolo scorso abbiamo appreso che un
corpo di grande massa deforma, incurvandolo, lo spazio-tempo circostante in modo che anche un raggio di luce che passi nelle sue vicinanze ne viene un po’ deviato. Un corpo celeste abbastanza
grande può arrivare a deformare lo spazio-tempo fino al punto di inghiottirlo. Un buco nero è proprio il residuo di un tale evento: lo spazio-tempo vi si è incurvato a tal punto che ha ceduto ed è rovinato sul corpo stesso, così che qualsiasi cosa vi si avvicini troppo ne viene risucchiato e ci cade dentro. Anche la luce vi va a morire ed è questa l’origine del nome: niente ne può più riuscire, nemmeno la luce.
Probabilmente al centro di ogni galassia esiste un buco nero, che quindi sarà molto difficile da osservare direttamente. D’altra parte ci viene
detto che chi si avvicinasse a un buco nero e ne venisse risucchiato probabilmente non si accorgerebbe di niente. Gli altri vedrebbero il suo tempo rallentare progressivamente e le sue dimensioni contrarsi, ma lui non ne avrebbe una percezione soggettiva cosciente.
Tempi che rallentano e dimensioni spaziali che si contraggono fanno parte dell’armamentario logico della teoria della relatività. Se si guarda
al cosmo e alla forza di gravitazione che vi domina, si possono osservare appunto le strane cose che abbiamo appena ricordate. Le masse,
soprattutto le grandi masse, incurvano lo spaziotempo
circostante, facendo per esempio rallentare gli orologi che si trovano nelle vicinanze. Se il campo gravitazionale è molto forte, il rallentamento
è sensibile, ma ci può essere una lieve differenza nella misura del tempo anche fra due orologi identici funzionanti in un grattacielo, uno
nello scantinato e l’altro sul tetto. Il primo andrà un po’ più lento del secondo perché si trova a operare in un campo gravitazionale più intenso, anche se di poco, come è stato sperimentalmente
accertato qualche anno fa.
La concezione dello spazio-tempo offerta dalla teoria della relatività generale ha una grandiosità inarrivabile. In questa visione sommamente
astratta tutta la fisica del cosmo si può ricondurre a geometria, la geometria dello spaziotempo.
Un pianeta o una cometa orbitano intorno a una data stella perché quella è «la loro via». Lo spazio-tempo intorno alla stella è deformato da
quella in modo tale che il pianeta o la cometa seguano naturalmente una data traiettoria, perché è quella permessa dalla struttura locale dello spazio- tempo. Spazio, tempo, massa e gravita si fondono allora in un’unica equazione semplice e grandiosa che descrive le varie realtà locali e l’intero universo.
Ma c’è un piccolo problema: la risoluzione di questa equazione mostra incontrovertibilmente che l’universo non può essere statico ma deve
espandersi in continuazione. La teoria della relatività
generale ha ricevuto negli anni innumerevoli conferme e l’idea che l’universo si stia espandendo è divenuta ormai familiare anche all’uomo
della strada. D’altra parte, il fatto che il cielo di notte sia scuro, invece che di una luminosità accecante, non può essere spiegato se non supponendo che le stelle e le galassie si allontanino costantemente, fuggendo da noi e le une dalle altre. Non è parimenti possibile comprendere perché a lungo andare stelle e galassie non precipitino
le une sulle altre sotto l’azione della forza di gravità, se non invocando l’esistenza di un meccanismo di fuga e di espansione.
L’universo nella sua totalità si espande e si può pensare che ci sia stato un momento in cui tutto era concentrato in un unico punto di densità
infinita. Si ritiene che ciò sia accaduto circa quattordici miliardi di anni fa. In quel momento c’è stata una gigantesca esplosione cui è stato
dato il nome di Big Bang, il grande schianto, e da allora l’universo ha cominciato a espandersi.
Quello che non sappiamo è se l’espansione durerà per sempre o arriverà un momento, per quanto remoto, in cui l’universo smetterà di
espandersi e comincerà a contrarsi. Sono scenari da brivido, ma esistono numerosi studi che rendono il tutto scientificamente ineccepibile. Molti
autori ritengono anche che il fenomeno dell’espansione dell’universo sia la causa ultima, se non unica, dell’irreversibilità degli eventi della
nostra vita. Se c’è qualcosa di tanto fondamentalche è così palesemente asimmetrico, non è impossibile pensare di ricondurre tutte le altre
asimmetrie temporali a questa.
Negli immensi spazi siderali si aggirano quindi oggetti che incurvano con la loro stessa presenza il continuo spazio-temporale fino a
inghiottirlo. Ma non è finita qui. In anni recenti si è cominciato a sentir parlare di cose ancora più misteriose e affascinanti, come la materia oscura e l’energia oscura. Per spiegare perché l’universo si espanda all’attuale velocità, occorre pensare che contenga molta più materia di quella che riusciamo a osservare. Questa ipotetica materia è stata definita oscura perché non riusciamo a vederla e non ne sappiamo niente. Inoltre, comunque la si possa spiegare, l’attuale velocità di espansione dell’universo sta aumentando.
Le galassie fuggono le une dalle altre sempre più in fretta. Ci deve essere qualcosa quindi che le allontana e che bilancia e sovrasta la forza di
gravita che tenderebbe a frenarne la fuga. Questa pressione interna della fabbrica del cosmo è stata chiamata energia oscura e nessuno ha al momento la più pallida idea di che cosa possa essere. La materia oscura e l’energia oscura potrebbero rappresentare tra il 95% e il 97% del contenuto dell’universo, lasciando alla materia che conosciamo un mero 3%!
Nel considerare i mondi dell’infinitamente piccolo e dello straordinariamente grande non possiamo che affidarci ad analogie o a immagini mentali più o meno azzardate. Oppure a formule matematiche, quelle formule che per quanto riguarda gli oggetti del nostro mondo sono poco più che riassunti di un gran numero di affermazioni, ma che per i fenomeni che hanno luogo in questi mondi remoti rappresentano quasi l’unica forma possibile di conoscenza e di previsione.
Eppure, nonostante tutte le nostre difficoltà ad afferrare le leggi di questi mondi remoti, è la nostra stessa esistenza di esseri viventi e intelligenti
che costituisce una garanzia per la realtà del gigacosmo e del microcosmo, anzi la richiede.
Ne fa una condizione necessaria se non sufficiente perché noi possiamo essere così come siamo. Vediamo perché.
Se non esistesse, infatti, l’infinitamente piccolo, la materia vivente non esisterebbe come tale. Anche un tavolo o una roccia sono costituiti
di molecole e di atomi ma per comprendere molte delle loro proprietà questo fatto può essere momentaneamente ignorato. Non così per la vita, né per la vita intelligente. Un essere vivente è costituito di cellule che sono necessariamente piccole e contengono organuli e microapparati
ancora più piccoli e per poter pensare deve possedere anche un numero imponente di cellule nervose.
Le cellule sono piccoli mondi organizzati e sufficientemente autonomi che non possono che essere formati da un numero enorme di unità
costitutive elementari. Se i mattoni del mondo fossero delle dimensioni a noi familiari, anche solo dell’ordine dei millimetri, non ci sarebbero esseri viventi e noi non ci saremmo.
Per essere vivi bisogna essere costituiti di parti piccole, che contengono altre parti ancora più piccole che interagiscono continuamente tra
di loro. Se le cellule nervose non fossero, inoltre, sufficientemente piccole da convivere a miliardi nel nostro corpo e nella nostra testa e non si toccassero tra di loro con contatti ancora più piccoli, noi non saremmo in grado di pensare.
Nel solo nostro cervello ci sono per esempio cento miliardi di cellule nervose. Si tratta di un numero enorme, astronomico nel vero senso
della parola, perché cento miliardi sono le stelle della galassia e cento miliardi sono anche probabilmente le galassie dell’universo. Per non parlare
della miriade di microconnessioni, chiamate in gergo tecnico sinapsi, che mettono in contatto tra di loro le varie cellule del cervello. Gè ne sono in
media diecimila per cellula. Se moltiplichiamo diecimila per cento miliardi otteniamo la sbalorditiva cifra di un milione di miliardi. Il nostro
cervello contiene quindi un milione di miliardi di connessioni, più di qualsiasi calcolatore elettronico esistente al momento sulla terra. Non meraviglia che siamo capaci di prestazioni mentali fuori dell’ordinario e che siamo anche incredibilmente diversi l’uno dall’altro: basta una connessione
allacciata in una maniera invece che in un’altra ed ecco che due cervelli non sono più uguali e danno vita a menti e coscienze diverse e
costitutivamente uniche.
Il fatto che siamo organismi viventi e che abbiamo un cervello piuttosto potente lo dobbiamo insomma all’esistenza del mondo del piccolissimo
con tutte le sue stupefacenti proprietà. Ma è vero anche l’inverso. Se l’universo non fosse tanto grande, non potrebbe avere una storia abbastanza lunga alle spalle. Abbiamo visto che, come si pensa, l’universo abbia approssimativamente quattordici miliardi di anni: l’universo fisico è tanto grande perché è da tanto tempo che sta lì e si espande. Se fosse stato più piccolo e la sua storia fosse stata più breve, non ci sarebbe stato il tempo per alcune stelle di esistere e di «sputare»
gli atomi degli elementi pesanti o di generare i pianeti, né per alcuni pianeti di raffreddarsi al punto da sopportare la vita e arrivare a pullulare
di strane creature che possono vivere solo a certe temperature e in condizioni ambientali relativamente stabili.
In conclusione, abbiamo serissimi problemi a raffigurarci il molto grande e l’eccezionalmente piccolo, ma la nostra stessa esistenza ne esige e
giustifica l’esistenza: il piccolo perché senza di quello non ci sarebbe né vita né intelligenza; il grande perché se l’universo non fosse stato così
grande non ci sarebbe stato il tempo materiale perché si formasse la nostra casa comune, la terra, e si potesse avere su di essa un’evoluzione
biologica di tale estensione da portare ai gigli, ai colibrì e agli esseri umani.
Anche la conoscenza della natura biologica ha fatto enormi progressi e ha introdotto punti di vista e concetti profondamente nuovi, anche
senza tirare in ballo la genetica e la biologia molecolare. La teoria dell’evoluzione biologica, il nocciolo duro del concetto di natura, ci ha
costretto a guardare le cose del mondo, cioè della natura, con occhi molto diversi e con una logica tutta particolare. La zoologia, l’ecologia e
l’etologia ci hanno offerto da parte loro una visione più dettagliata e approfondita delle dinamiche biologiche naturali. Colpisce quindi il
fatto che spesso quando si contrappone la natura alla cultura, soprattutto in questioni che coinvolgono l’etica e la bioetica, ci si avvale di una visione della natura stessa che risale a decenni,se non a secoli fa.
Non si può affermare, secondo me, che «la natura si comporta cosi», oppure che «questo è secondo/contro natura», se non si conosce la
natura stessa.
Non ha diritto di parlare di natura chi della natura non sa nulla: la natura va studiata, prima di parlare in suo nome. Eppure si assiste quotidianamente allo spettacolo di persone anche autorevoli che si richiamano di continuo a fenomeni e principi «di natura» che in genere non conoscono e che nella maggior parte dei casi si inventano di sana pianta. Non c’è niente di più immorale, per me, che inventarsi principi morali ad hoc, soprattutto se fondati su un ipotetico comportamento della natura.
Senza contare che noi uomini non abbiamo accettato come oro colato tutto quello che la natura biologica pratica e impone agli animali non
umani. Tutt’altro: certe cose profondamente naturali a noi non sono piaciute e non piacciono. A noi non piace che chi è nato geneticamente svantaggiato subisca tutte le conseguenze del suo stato.
Non piace che i bambini muoiano in gran numero, falcidiati dalle più tremende, ma «naturali», malattie. Non piace che soccombano i deboli, i
sofferenti e gli anziani. Non piace perché consideriamo gli altri come individui, che hanno impiegato tanto tempo a crescere, a formare la loro individualità personale e con i quali possiamo avere avuto una comunanza di esperienze e di vita.
Gli altri esseri umani sono per noi potenziali parenti, se non potenziali «noi stessi», poiché la nostra esperienza interiore ci fa toccare con mano
che cosa voglia dire soffrire e perdere la speranza e perché siamo abituati ad attribuire agli altri i nostri stessi pensieri e le nostre stesse sensazioni.
Aiutando gli altri aiutiamo noi stessi. Per le nostre esperienze interiori e per la lunghezza del periodo nel quale siamo stati bisognosi di aiuto e
abbiamo successivamente fornito ai nostri figli aiuto e protezione.
Siamo eterni figli e genitori e pensiamo di poter comunque essere utili. Tale convinzione ci ha portato a sviluppare forme di conforto sociale
inusitate e da una certa epoca storica in poi forme di soccorso materiale assolutamente senza precedenti.
La medicina e la chirurgia ci offrono oggi tutti i motivi per tentare di essere d’aiuto a chi soffre e non possiamo non compiacerci di tali successi. Se la pietà è oltre un certo livello innaturale,i progressi tecnici che quella ci ha ispirato possono far tornare i conti e darci ragione oltre la natura e al di sopra di essa. Siamo orgogliosi di essere come siamo, proprio perché per moltissimi aspetti della vita ci siamo affrancati dai dettami della natura e dalle imposizioni del destino.
E bene ricordare però che la natura si può trascendere ma non ignorare.
Occorre sapere come opera e, entro certi limiti, come «ragiona».
La natura ha sempre ragione, dal suo punto di vista. È giusto quindi superarla, come del resto abbiamo sempre fatto, ma è anche giusto comprendere le sue ragioni, non per rassegnarvisi, ma proprio per afferrarne il significato ed eventualmente trascenderlo.
Per quanto riguarda in particolare la morale individuale e collettiva, guai se seguissimo in tutto e per tutto la logica della natura. Non che la natura non abbia principi -ne ha tanti e molti utili anche per il nostro comportamento- ma il nostro senso morale si è sviluppato come una cosa nostra, un portato della nostra cultura, a volte in consonanza
e a volte in dissonanza con i principi naturali.
Occorre quindi valutare e giudicare caso per caso, utilizzando la ragione e la pietà umana, senza pregiudizi e apriorismi, soprattutto se basati su una
falsa conoscenza della natura e dei suoi principi.
EDOARDO BONCINELLI
Professore emerito, Università Vita e Salute di Milano
Una fredda nebbia illividisce il cielo,
le notti incominciano prima.
Tutti conoscono il declino,
ma pochi ne discernono la linea di confine.
Cher03@hotmail.it
|