|
RE: FRNP - i nodi vegono al pettine
"
La più recente verifica sperimentale di questo evento si è avuta nella notte del 28 settembre 2003 alle ore 3.01, quando la caduta di un albero sulla linea ad alta tensione che collega il Piemonte alla Svizzera ha bruscamente interrotto il flusso di circa 2000 MW verso la centrale di Rondissone, la cui capacità di reazione non era adeguata a compensare tale deficit. La richiesta immediata di compensazione locale fatta alla linea francese, che in quel momento immetteva in Italia circa 4000 MW, portava ad oscillazioni di tensione e di frequenza ritenute pericolose per la stabilità della stessa rete francese con il conseguente distacco dalla rete italiana. In pochi minuti sono venuti a mancare altri 4000 MW, cioè in totale circa 6000 MW sui 27000 MW che alimentavano la rete in quel momento. L’impatto di questo transiente sull’intero sistema portò ad un abbassamento della frequenza sull’intera rete, che si ridusse in pochi minuti da 50 Hz al valore (critico per i sincronismi) di 47,5 Hz, imponendo interventi di distacco a catena sul Nord, ma anche sui generatori dell’estremo Sud, fino alla Sicilia.
La richiesta immediata di potenza ha sovraccaricato l’impianto di Rondissone causandone lo spegnimento automatico. Il sistema di controllo della rete ha reagito iniziando a distaccare i carichi e a richiedere l’intervento di tutti i generatori della riserva del Nord Italia. Purtroppo, a causa dell’ora notturna, essi erano in gran parte spenti. Il black out riguardò tutta l’Italia: al Sud per qualche minuto, al Nord per qualche ora ed in alcune zone del Nord Est il blocco durò circa 24 ore con danni enormi.
La lezione appresa da questo evento può essere grossolanamente riassunta dicendo che la perturbazione causata dalla mancanza improvvisa di 6000 MW sulla situazione d’equilibrio in rete di 27000 MW ha provocato il black out totale. L’intervento dei 21000 MW di generatori termoelettrici attivi con il loro scarso margine di riserva non ha permesso la compensazione dello squilibrio ed il recupero della stabilità della rete. Detto in termini relativi: una variazione dello stato di equilibrio della potenza in rete pari al 22% (rispetto al livello operativo) e al 28% (rispetto alla potenza rotativa attiva) ha determinato il black out (naturalmente nelle condizioni della configurazione di rete del 28 settembre 2003).
L’evento non ci consente di stabilire quale sia il limite esatto di tolleranza per l’intensità della perturbazione da parte del sistema di controllo della rete, tuttavia l’esperienza ha dimostrato che tale limite deve essere posto sicuramente sotto al 28% della quantità di potenza dei generatori rotativi attivi in rete. Da questo punto di vista lo studio del CESI (limite al 20-25%) appare in perfetto accordo.
Veniamo ora al caso in cui sia presente in rete la potenza fotovoltaica Pph. Supponiamo di trovarci in un momento statisticamente fortunato di piena insolazione sulla maggior parte degli impianti, mentre in cielo sono presenti grosse nuvole sparse che corrono spinte dal vento. Il gestore della rete, come abbiamo visto, ha ridotto della stessa quantità la potenza Pg dei generatori convenzionali fino al valore Pg’ = (Pc - Pph). In ogni caso, temendo l’aleatorietà del fotovoltaico, li ha mantenuti attivi, a bassa potenza, in modo da poterli riportare a regime rapidamente nell’eventualità di variazioni della curva di produzione oraria.
Supponiamo ora il caso peggiore, cioè che il nostro momento fortunato si trasformi improvvisamente in uno sfortunato, statisticamente improbabile, ma pur sempre possibile, in cui la maggior parte degli impianti siano oscurati dalle nuvole simultaneamente. La potenza fotovoltaica subisce un brusco decremento con conseguente variazione di ampiezza pari a Pph e la perturbazione si trasmette istantaneamente alla rete. Il sistema automatico di controllo interviene nel tentativo di compensare la variazione di tensione e frequenza facendo ricorso alla riserva di potenza dei generatori rotativi rapidi, in quel momento attivi in rete.
Come si può costatare, il caso è del tutto analogo a quello sopra descritto del distacco della linea svizzera che causò il black out nel 2003.
Indichiamo genericamente con K il limite di accettazione della rete per l’immissione di potenza intermittente come frazione della potenza Pg dei generatori di riserva in quel momento attivi. Naturalmente, data la natura statistica dell’evento, il valore di K sta ad indicare che il superamento del limite non provoca sicuramente il black out, ma soltanto che la probabilità dell’evento è fortemente aumentata.
Si possono dare due casi per l’ampiezza della variazione della potenza fotovoltaica:
1. DeltaPph < K Pg; 2. DeltaPph > K Pg.
Per quanto abbiamo visto, nel primo caso il sistema di controllo può recuperare l’equilibrio utilizzando la riserva di potenza, mentre nel secondo si può rischiare il black out, qualora non si riuscisse ad effettuare in tempo il distacco d’emergenza dei carichi, cosiddetti interrompibili.
Il verificarsi dell’evento estremo non solo dipende dalla disponibilità di sufficiente capacità di riserva per compensare l’ampiezza della variazione, ma dipende anche dalla rapidità con cui si realizza tale variazione. Infatti la possibilità di recupero da parte del controllo della caduta di frequenza (prima che essa scenda sotto il limite dei sincronismi) dipende dalla rapidità di risposta dei generatori e dalla necessità di mantenere tale risposta entro condizioni di sottocriticità per evitare le oscillazioni del numero dei giri. La risposta immediata ai transienti troppo bruschi non è permessa e in tali condizioni le variazioni di frequenza possono portare i generatori allo spegnimento in protezione.
Probabilità del black out
Come si è detto, il limite di penetrazione K ha un significato probabilistico. Se la variazione relativa DeltaPph/Pg > K, ciò non significa che è certo il black out, significa solo che esiste una probabilità finita che l’evento possa avvenire. Naturalmente, il rischio dei danni che tale caso può procurare dovrebbe essere sufficiente a mettere in allarme il GSE circa l’aggiunta in rete di nuova potenza intermittente.
Allo stato attuale, non risulta che ci sia stata una valutazione ufficiale del limite da parte del GSE, anche se, limitatamente al caso particolare della rete siciliana, la Terna ha sollevato qualche dubbio di tenuta rispetto alla quantità di potenza eolica ulteriormente collegabile.
Tutto ciò premesso, andiamo avanti con le nostre considerazioni. Consideriamo affidabile il valore di K = 25%, indicato dallo studio CESI e convalidato dal black out del 2003 e cerchiamo di ricavare il valore limite di DeltaPph.
Per far questo abbiamo bisogno di stabilire con una certa sicurezza il valore di Pg e ciò non è affatto facile, perché le informazioni circa le centrali elettriche sono state classificate come riservate a partire dal maggio 2008. I dati pubblicati dalla Terna riguardano soltanto la potenza totale termoelettrica, che è di 79430 MW alla fine del 2010, senza alcuna specificazione circa il tipo e l’ubicazione delle centrali. Questo dato costituisce l’estremo superiore per Pg, poiché esso comprende anche i generatori utilizzati soltanto nei momenti di punta.
Dall’altro lato possiamo vedere nei diversi diagrammi giornalieri di carico, pubblicati dalla Terna, che nelle ore meridiane la potenza alla base del picco d’assorbimento si aggira intorno ai 38000-40000 MW, mentre quella di picco può arrivare a oltre 50000 MW. Poiché la potenza di picco è fornita essenzialmente dalle centrali idroelettriche e turbo gas, possiamo ragionevolmente concludere che la potenza di base e intermedia provenga tutta dai generatori termoelettrici. Pertanto, considerato un adeguato margine di riserva, possiamo supporre che la potenza attiva disponibile possa assommare a circa 45000 MW e tale valore può essere considerato come l’estremo inferiore per Pg.
Infine, da una lista delle centrali elettriche italiane pubblicata da Wikipedia, sicuramente non aggiornata, si ricava che la potenza totale dei generatori termoelettrici di taglia superiore a 100 MW (quelli utilizzabili per la riserva) è pari a 47500 MW.
In conclusione, possiamo ragionevolmente assumere che la potenza dei generatori rotativi attivi nella rete è all’incirca Pg = 50000 MW. Di conseguenza, il rischio di black out dovrebbe presentarsi quando la potenza fotovoltaica Pph, immessa in rete, può subire casualmente una variazione superiore a DeltaPph = K Pg = 12500 MW.
Per l’incertezza con cui si conosce il livello della potenza rotativa Pg e il significato probabilistico di K, questo numero non va preso come una misura precisa del limite d’accettazione. Esso, piuttosto, va considerato come un’indicazione del livello di penetrazione in rete delle fonti intermittenti, intorno al cui valore ci si deve incominciare a preoccupare per il rischio di black out.
Ricordiamo che, in caso di annuvolamento nelle ore meridiane, deltaPph = Pph – Pph0, dove Pph0 rappresenta il livello inferiore a cui si porta la potenza degli impianti per l’oscuramento del sole. Il funzionamento del fotovoltaico è tale che la potenza erogata va a zero solo in assenza completa di luce, cioè di notte; quindi, anche per un annuvolamento profondo, gli impianti continuano ad erogare potenza per circa il 30% della piena illuminazione, (livello corrispondente alla residua luce diffusa). Avremo allora Pph0 uguale a circa 0,3 Pph e quindi DeltaPph = 0,7 Pph, cioè la massima variazione possibile è pari al 70% della potenza fotovoltaica istallata.
L’annuvolamento improvviso del cielo, simultaneamente sopra tutti gli impianti, è un evento estremamente improbabile, data la loro distribuzione diffusa su tutto il territorio nazionale. Tuttavia, a scopo cautelativo, immaginiamo che tale caso peggiore possa verificarsi.
Ricordiamo, inoltre, che anche la potenza eolica istallata Peol è intermittente e, quindi, anch’essa può improvvisamente variare profondamente. La possibilità della maggiore variazione si verifica in corrispondenza dell’ intensificazione del vento, quando la velocità delle raffiche arriva a superare il limite di cut out degli aerogeneratori. In questo caso, il sistema automatico di protezione mette in bandiera le pale riducendo rapidamente a zero la potenza erogata dalle macchine. Pertanto, l’erogazione può passare bruscamente da Peol a zero con una variazione d’ampiezza DeltaPeol = Peol. Purtroppo ciò avviene di regola proprio in correlazione con il passaggio di una grande perturbazione atmosferica, quando è più probabile l’evento contemporaneo dell’oscuramento del sole sugli impianti fotovoltaici. Il risultato, (sempre in termini probabilistici del caso peggiore) è che la variazione dell’eolico si somma a quella del fotovoltaico e si può avere una variazione totale della potenza immessa in rete:
DeltaP =DeltaPph + DeltaPeol = 0,7 Pph + Peol
Il rischio di black out inizia se e quando si dovesse superare il limite d’accettazione:
DeltaP = 0,7 Pph + Peol > 12500 MW
Per il fotovoltaico, questa condizione significa che la potenza installata compatibile con quella eolica dovrebbe mantenersi al di sotto del valore:
Pph = (12500 - Peol)/0,7
Il rapporto ultimo disponibile della Terna assegna all’eolico al 2010 una potenza istallata di circa 6000 MW, per cui la potenza fotovoltaica massima istallabile sarebbe Pph = 9300 MWp, ipotizzando che la potenza eolica non aumenti ulteriormente (cosa che si sta puntualmente verificando).
Fino a pochi anni fa, questo livello di potenza era considerato così lontano che sembrava prematuro stare a preoccuparsi del rischio di black out. I 7750 MW fotovoltaici, che risultano oggi collegati alla rete, si trovano ancora entro la zona di sicurezza, ma si stanno avvicinando molto al limite che può portare all’instabilità della rete con probabilità finita del black out.
Conseguenze del limite sul contributo energetico
Come abbiamo visto, il limite K è un concetto statistico che contiene un certo margine d’incertezza. Per questo motivo, si può discutere sulla sua entità in relazione ai fattori da cui esso dipende. Sulla sua esistenza, però, non si può avere incertezza, essendo il concetto conseguenza diretta dell’aleatorietà della produzione di potenza e dei suoi effetti sul sistema automatico di controllo della rete.
Pertanto, le fonti rinnovabili elettriche casualmente intermittenti, collegate direttamente alla rete senza accumulo, hanno un limite di penetrazione K.
L’energia elettrica prodotta congiuntamente da fotovoltaico ed eolico in corrispondenza di questo limite è data da:
E = K Pg H (MWh)
Dove H = 1350 è il numero di ore equivalenti di funzionamento a piena potenza mediato sulle due fonti rispetto alle medie nazionali di 1200 ore per il fotovoltaico e 1500 ore per l’eolico.
La richiesta totale di elettricità è stata nel 2010 di Eel = 326 106 MWh (vedi qui), per cui il contributo massimo delle rinnovabili intermittenti corrisponde ad una quota del fabbisogno elettrico di:
Q = E/Eel = (K Pg H)/Eel = 5,2%
Dove si è posto K = 0,25 e Pg = 50000 MW.
Pertanto, in termini di elettricità, le nostre fonti intermittenti potranno portare un contributo massimo intorno al 5,2%.
Ricordiamo, infine, che l’incidenza del settore elettrico sui consumi totali di energia è di circa il 35%. Quindi, in termini di energia primaria, il contributo delle fonti intermittenti sul bilancio energetico nazionale sarà marginale, essendo confinato intorno al 2%. Le attese poste su queste fonti per il risanamento ambientale emergono come fortemente ridimensionate.
Questo deludente risultato è dovuto indubbiamente al valore basso del limite di penetrazione in rete da noi ipotizzato per i calcoli (25%). Tuttavia, se assumessimo un valore doppio, il contributo si porterebbe intorno al 4%, rimanendo ugualmente marginale rispetto al fabbisogno energetico.
La conclusione è che la presenza in sé del limite di penetrazione in rete introduce un tetto al possibile contributo delle fonti intermittenti e, quindi, all’ulteriore sviluppo del mercato. Se vogliamo realizzare pienamente le loro indubbie potenzialità, come d’altra parte impone la crisi climatica, dobbiamo assolutamente rimuovere il vincolo dell’intermittenza, passando ad un nuovo modello di applicazione dei sistemi che contempli anche l’accumulo dell’energia.
L’approssimarsi delle complicazioni di gestione della rete, dovute al raggiungimento del limite, impone che tale provvedimento strategico sia preso in tempi relativamente brevi. Diamoci da fare!
at 6:00 PM
"
Ti faccio i complimenti drugo ottimo topic ed ottimo link!! era ora che il forum accolga persone con intelletto e non i soliti sparatori di balle spaziali.
Cosa posso dirti, per quel che so io da parte dei tecnici ENEL ci si lamenta del problema " Armoniche " in rete, come io ho spiegato molti topic fa le fonti rinnovabili come Fv non generano una onda pura sinosoidale come i generatori rotativi!!
Per farti un esempio nella provincia di grosseto parti per la prima volta in italia un esperimento che consisteva nella distribuzione di internet attraverso la linea elettrica ENEL, il risultato fu disastroso, le apparecchiature ed i converter sono collassati i tecnici hanno abbandonato il progetto ha causa delle migliaia di interferenze sulla rete causate dalla non regolarita della funzione dell'onda, ogni impianto Fotovoltaico immette in rete onde piene di armoniche chi mastica bene elettrotecnica sa benissimo cosa sono le armoniche di 3-5-9 ecc ecc.
Per il fatto del black out non mi preoccuperei piu di tanto, si stanno costruendo molte turbo-gas in italia tantissime!!, sempre a metano CH4 tanto noi dai combustibili fossili non ci separiamo....
"Io non ho paura del nucleare ma dell'uomo !" giampiero giulianelli
|

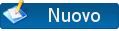










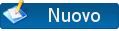

 Ricerca
Ricerca Lista utenti
Lista utenti Calendario
Calendario Aiuto
Aiuto

